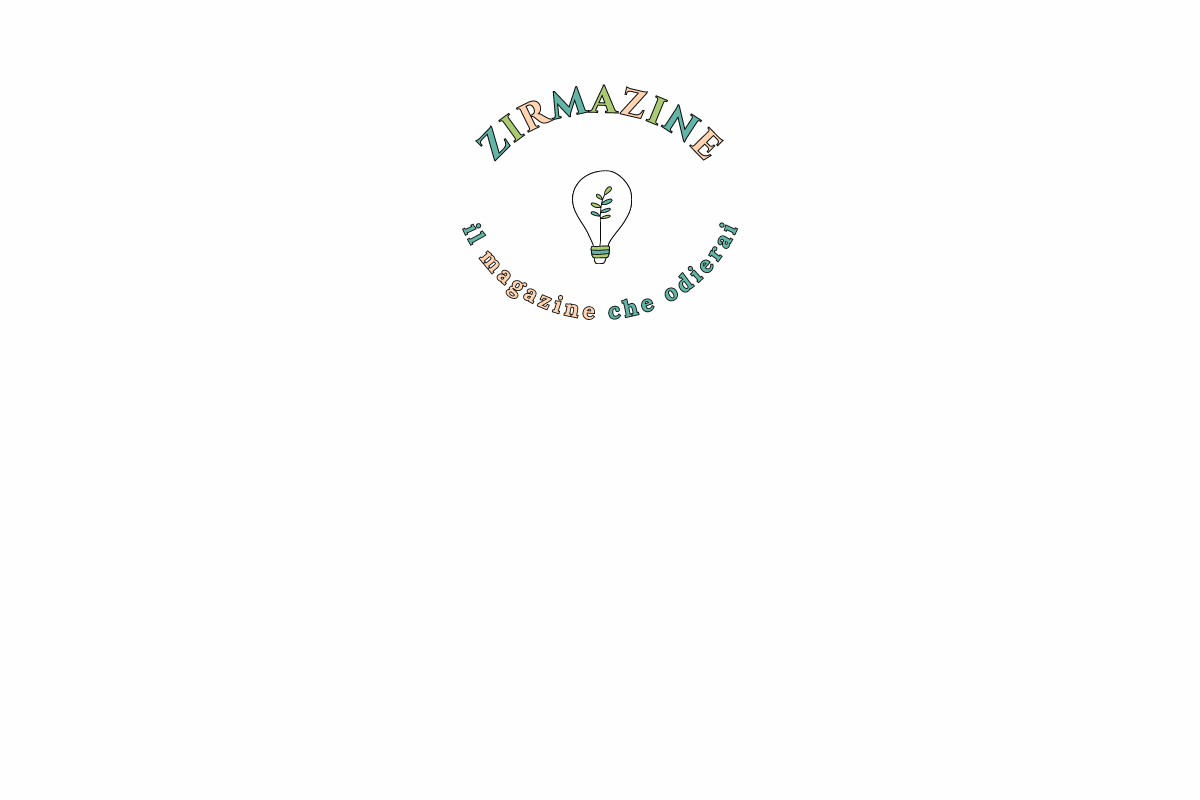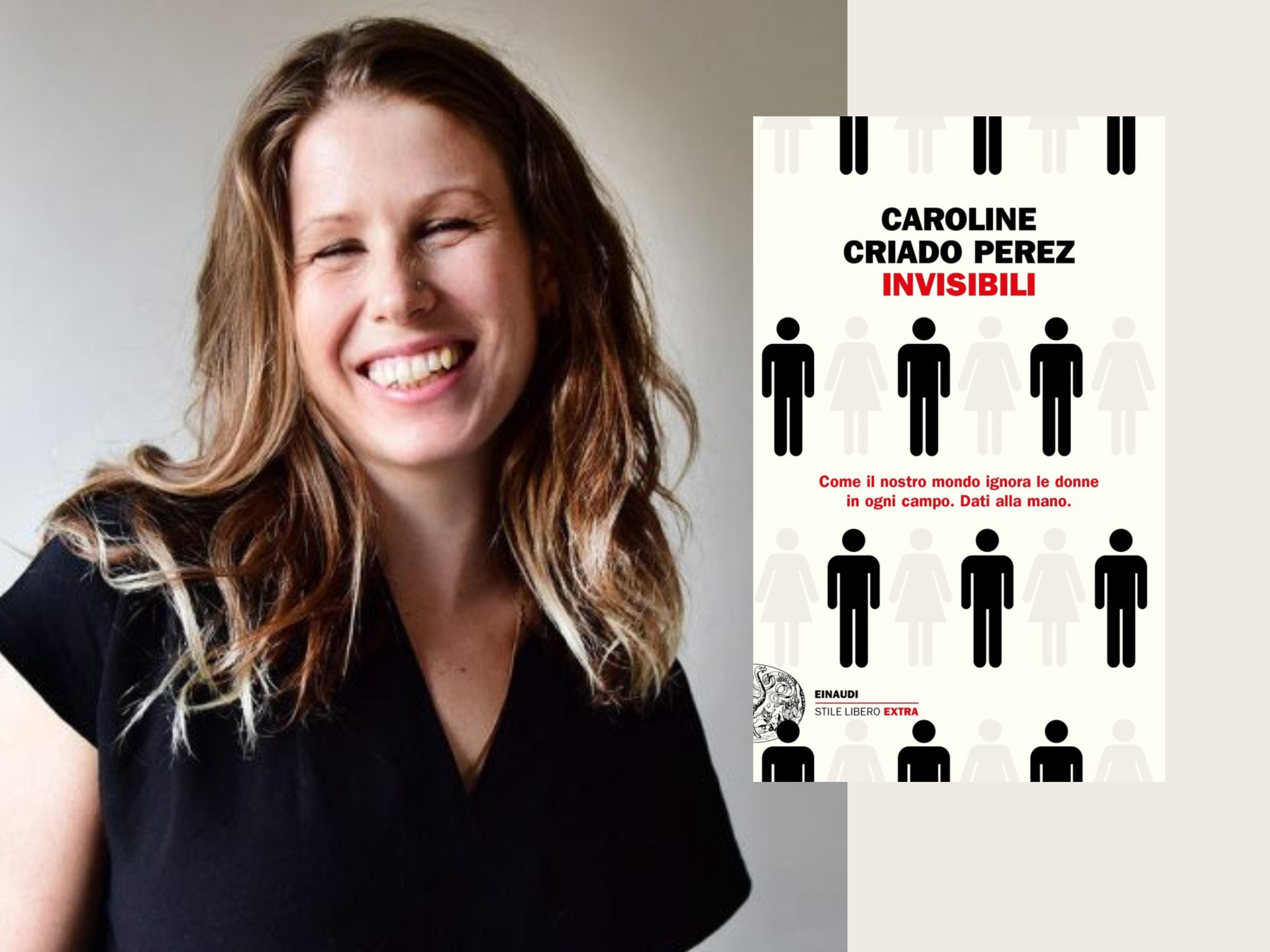
Il gender data gap – la mancanza o la scarsa rappresentazione di dati specifici sulle donne in diversi ambiti della società, dalla ricerca scientifica alla progettazione tecnologica, dalle politiche pubbliche alla medicina –ha reso le donne invisibili. Dai dispositivi di sicurezza pensati per corpi maschili ai sintomi di infarto non riconosciuti, considerando il maschile come standard universale, le decisioni basate su dati incompleti hanno penalizzato e penalizzano ancora le donne in molti ambiti. Nel libro Invisibili. Come il nostro mondo ignora le donne in ogni campo. Dati alla mano, Caroline Criado Perez denuncia questa distorsione e suggerisce delle azioni di cambiamento per colmare questo gap.
Il brano che segue è un esempio lampante di questa rimozione, che riguarda ogni aspetto della nostra cultura. Non è solo una questione di nomi dimenticati nei libri di testo: è il racconto di un mondo che per secoli ha deciso chi meritava di essere ricordato e chi no, lasciandoci con una visione incompleta e parziale della realtà. Criado Perez dimostra come questa esclusione non sia stata casuale, piuttosto il risultato di scelte precise che hanno dato vita a un canone culturale limitato, spacciando per oggettiva una narrazione che ignora di fatto metà del genere umano.
Criado Perez continua ad approfondire questi temi anche nella sua interessante e ironica newsletter Invisible Women, dove esplora le conseguenze dell’invisibilità di genere nella società di oggi.
Di valutazioni soggettive mascherate da giudizi obiettivi è pieno il mondo. Nel 2015 una liceale inglese di nome Jesse McCabe notò che delle sessantatre opere musicali menzionate nel suo programma di studi non ce n’era nemmeno una che fosse stata scritta da una donna. La commissione esaminatrice, interpellata in proposito, le rispose cosí: «Data l’importanza secondaria delle compositrici nella tradizione classica occidentale (come in tutte le altre, del resto), le musiciste degne di considerazione sarebbero ben poche». È da notare il modo in cui è stata formulata la risposta: poiché era impossibile dire che non ci sono compositrici donne (la sola International Encyclopedia of Women Composers ne elenca piú di seimila), la commissione di esame si è appellata al canone, ovvero al corpus delle opere considerate fondamentali nella genesi della cultura occidentale.
L’opinione corrente è che il canone sia un derivato oggettivo dei trionfi e degli insuccessi conseguiti sulla scena musicale, ma in verità non è che l’ennesimo giudizio soggettivo formulato da una società iniqua. Le donne sono state estromesse in blocco dal canone perché nel corso della Storia quello che si considera successo in campo musicale è sempre stato al di fuori della loro portata. La loro musica, se mai gli era concesso di comporla, veniva eseguita soltanto in audizioni private negli ambienti domestici. La realizzazione di grandi opere orchestrali, cosí importanti per la reputazione di un musicista, gli era vietata perché «sconveniente»1. Per le donne la musica era un «ornamento», non una carriera2. Non piú tardi del secolo scorso Elizabeth Maconchy (la prima donna della Storia a presiedere l’associazione dei compositori britannici) veniva frustrata nelle sue ambizioni da editori come Leslie Boosey, che «da una donna accettavano solo canzoncine».
E se anche le «canzoncine» che gli era permesso comporre fossero state sufficienti a guadagnare loro un posto nel canone, le donne non avrebbero comunque avuto le risorse o la posizione sociale necessarie per mantenerlo. Nel saggio intitolato Note dal silenzio, Anna Beer mette a confronto Barbara Strozzi, prolifica compositrice seicentesca che «nel corso della sua vita riuscí a stampare piú musica di ogni altro compositore del tempo»3 con uno dei suoi contemporanei maschi, Francesco Cavalli. Nella sua veste di Maestro della cappella ducale di San Marco a Venezia (incarico a quei tempi inaccessibile alle donne) Cavalli aveva soldi e prestigio sufficienti a far sí che tutte le sue opere, comprese le molte ancora non pubblicate, fossero custodite presso una biblioteca. Poteva permettersi di pagare un archivista che se ne prendesse cura, e persino dare disposizioni affinché dopo la sua dipartita le messe da lui composte fossero eseguite negli anniversari della morte. Non disponendo di altrettante risorse, Barbara Strozzi e la sua musica erano destinate all’oblio: per questo dico che insistere sul valore di un canone che esclude le donne equivale a perpetuare le ingiustizie del passato.
L’esclusione delle donne dalle posizioni di potere, se da un lato ne spiega l’apparente assenza dalla storia culturale, dall’altro viene utilizzata come scusa per giustificare un insegnamento della Storia che si concentra in modo quasi esclusivo sulle vite degli uomini. Nel 2013 si è scatenata in Inghilterra una vera e propria battaglia su questo tema. Uno degli schieramenti in campo, capeggiato dall’allora segretario di Stato per l’Istruzione Michael Gove, proponeva di rinnovare i programmi scolastici per l’insegnamento della Storia favorendo un «ritorno all’essenziale»4. Come un’armata di novelli Thomas Gradgrind, lui e i suoi accoliti sostenevano che agli scolari si dovessero insegnare i «fatti»5; che gli si dovessero fornire «le basi della conoscenza».
Peccato che quell’insieme di «fatti» essenziali, di «fondamenti dello scibile» che ogni scolaro inglese avrebbe dovuto apprendere, contasse tra i suoi numerosi difetti la quasi totale assenza di figure femminili. Nel programma di storia Livello due (per i bambini dai sette agli undici anni) non compariva nessuna donna all’infuori delle due regine Tudor. Nel Livello tre (tra gli undici e i quattordici anni) i personaggi storici femminili erano soltanto cinque, quattro dei quali (Florence Nightingale, Mary Seacole, George Eliot e Annie Besant) raggruppati in un’unità didattica intitolata Il nuovo ruolo delle donne: il che lasciava intendere, non a torto, che nel resto del programma si sarebbe parlato solo di uomini.
Nel 2009 l’autorevole storico inglese David Starkey rimproverò ad alcune sue colleghe di dedicare eccessiva attenzione alle mogli di Enrico VIII, tralasciando la figura del monarca che, a suo dire, avrebbe dovuto essere «al centro del palcoscenico»6. Mostrando disinteresse per la «soap opera» della vita personale di Enrico VIII, Starkey rivolgeva la propria attenzione alle conseguenze politiche del suo regno e sosteneva che «a raccontarla nel modo corretto, la storia europea (esclusi gli ultimi cinque minuti) è essenzialmente una storia di maschi bianchi, perché il potere è sempre stato nelle loro mani, e qualsiasi altra teoria non è che una mistificazione».
L’affermazione di Starkey si basava sul presupposto che quanto accade nella sfera privata sia irrilevante. Ma è davvero cosí? Consideriamo per esempio la vita privata di Agnes Huntington, per come ci viene rivelata dagli incartamenti processuali relativi ai suoi due matrimoni7. Scopriamo che Agnes aveva subito ripetute violenze domestiche, e che il suo primo matrimonio era stato avversato dalla famiglia di lei, contraria all’unione. La sera del 23 luglio 1345 Agnes fugge dalla casa del secondo marito, che l’ha appena aggredita e che piú tardi si presenta armato di coltello a casa del fratello di Agnes, per «convincerla» a tornare a casa. Credete ancora che le violenze subite da una donna del XIV secolo (e la sua impossibilità di autodeterminarsi) siano questioni private di nessuna importanza? E se fossero invece l’ennesimo episodio di una lunga storia di sudditanza femminile?
Tanto piú che la spartizione della vita in una sfera «pubblica» e una «privata» sembra arbitraria e priva di un reale fondamento, poiché pubblico e privato non fanno che contaminarsi a vicenda. Katherine Edwards, un’insegnante di storia che ha svolto un ruolo di primo piano nella lotta alle riforme di Gore, mi ha esposto i risultati di alcune recenti ricerche sul ruolo delle donne ai tempi della Guerra di secessione americana. Altro che irrilevanti! Secondo Edwards, «le donne e la loro concezione del ruolo femminile hanno seriamente nuociuto all’impresa bellica dei Confederati».
Le donne delle élite, sostiene Edwards, cresciute nel mito della propria inettitudine, erano del tutto incapaci di lasciarsi alle spalle un’idea del lavoro come tipica attività non-femminile: non riuscendo a sostituirsi ai loro uomini nelle mansioni che costoro avevano abbandonato per arruolarsi nell’esercito, scrivevano ai mariti implorandoli di disertare e tornare a casa. Le donne delle classi povere, dal canto loro, erano molto attive nella resistenza organizzata alle politiche della Confederazione, «non foss’altro perché morivano di fame e avevano necessità di nutrire le loro famiglie». Dunque un’analisi della Guerra di secessione che non tenga conto delle donne è due volte compromessa: non solo dall’assenza di dati di genere, ma anche da una comprensione lacunosa dei fenomeni che hanno portato alla nascita degli Stati Uniti. Questo sí che è un fatto degno di attenzione.
La storia del genere umano. La storia dell’arte, della letteratura, della musica. La storia dell’evoluzione. Ci sono state presentate come fatti oggettivi, ma in realtà nascondono un inganno, giacché sono distorte dalla mancata percezione di metà del genere umano, e persino dalle stesse parole che vorrebbero esprimere quelle mezze verità. Una mancata percezione che ha creato vuoti informativi, che ha alterato ciò che pensiamo di sapere su noi stessi e alimentato il mito dell’universalità maschile. E anche questo è un fatto.
Il mito dell’universalità maschile continua a condizionare l’immagine che abbiamo di noi stesse, e se c’è una cosa che è apparsa chiara negli ultimi anni è che il modo in cui ci vediamo non è affatto un problema secondario. L’identità è una forza poderosa: se scegliamo di ignorarla o travisarla, lo facciamo a nostro rischio e pericolo. Per citare tre esempi recenti: Trump, la Brexit, l’Isis sono fenomeni globali che hanno sconvolto l’ordine mondiale e sono anche, nel profondo, fenomeni identitari. Ma l’ottenebrante mascolinità camuffata da universalità senza distinzioni di genere ci induce a travisare o ignorare la nostra identità.
- Beer, Note dal silenzio. Le grandi compositrici dimenticate della musica classica, trad. di L. M. Pignataro, EDT, Torino 2019. ↩︎
- Benché elogiata come bambina prodigio, Fanny Hensel si sentí dire dal padre che «Forse la musica diventerà la sua professione [del fratello Felix Mendelssohn], mentre per te può e deve rimanere solo un ornamento». ↩︎
- Beer, Note dal silenzio cit. ↩︎
- http://www.telegraph.co.uk/women/womens-life/9790633/Will-Goves-posh-white-blokes-history-curriculum-ignore-women.html ↩︎
- www.telegraph.co.uk/education/educationopinion/9973999/Sorry-NUT-Goves-history-reforms-are-no-pub-quiz.html ↩︎
- http://www.telegraph.co.uk/culture/tvandradio/5077505/History-has-been-feminised-says-David-Starkey-as-he-launches-Henry-VIII-series.html ↩︎
- https://teachingwomenshistory.com/teaching-resources/medieval-women/ ↩︎